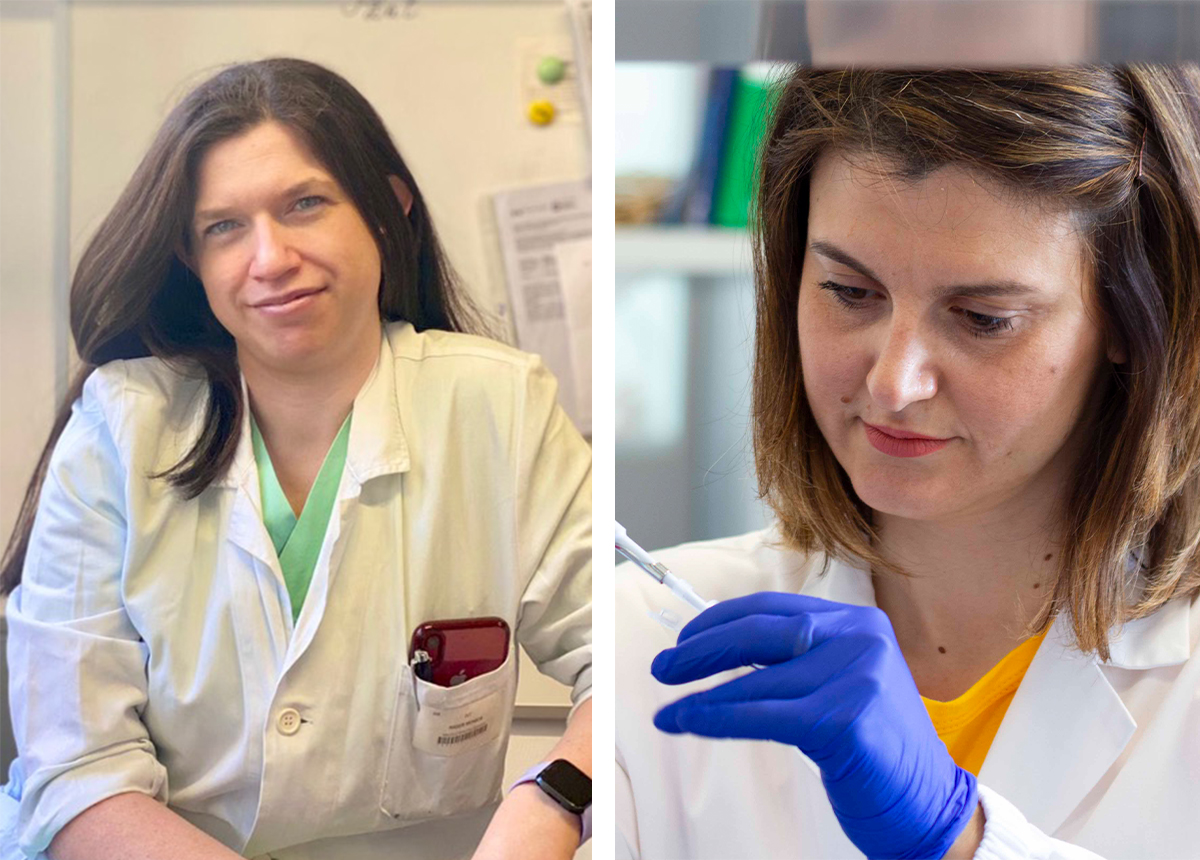L’11 febbraio si celebra la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Per l’occasione abbiamo intervistato Giulia Della Chiara, ricercatrice nelle cosiddette STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics e Monica Niger, ricercatriche e medico in oncologia under 35.
Giulia Della Chiara ha 40 anni, lavora all’IFOM, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, ed è una ricercatrice “pura”. Per intenderci, lei trascorre giornate intere in laboratorio, tra vetrini e microscopi e spesso il tempo sfugge di mano. Complici la passione e la voglia di arrivare a un traguardo, a una scoperta che, come ci ha raccontato, possa essere utile un domani ai pazienti. «Mi occupo di ricerca molecolare di base in campo oncologico», ci dice. «In particolare mi sono occupata negli ultimi 5 anni nel laboratorio del prof. Pagani qui in IFOM dello sviluppo di nuovi sistemi per studiare il tumore in una maniera più fisiologica possibile. Ancora meglio, generando degli organoidi, cioè dei piccoli avatar derivanti da campioni di tumore umano che coltiviamo e che usiamo per riprodurre appunto in vitro il tumore». Il compito di Giulia è di arrivare, come obiettivo finale, a ipotizzare nuove terapie future, a formulare ipotesi concrete su quelli che sono i talloni di Achille tumorali e come bersagliarli con dei farmaci ritagliati su misura in base al tipo di tumore. «La ricerca per me è la capacità di riuscire a trovare anche solo una risposta al quesito biologico che noi abbiamo di fronte tutti i giorni e tradurre questa risposta in possibili trattamenti per i pazienti. Questo per far capire che per me gli organoidi, appunto questi modelli che riproducono in vitro in maniera così fedele il tumore primario, sono motivo di grandissima soddisfazione per due ragioni. Intanto, rappresentano qualcosa che ho costruito partendo da zero nel laboratorio e inoltre, aspetto più importante, offrono la possibilità di pensare al paziente». Una grande soddisfazione, certo, ma ottenuta con sacrifici. «Sì, è vero, ma già durante la tesi magistrale ho avuto la fortuna di avere un professore che mi ha trasmesso la passione per la ricerca». Ricercatrice, ma anche donna. Come si combinano i due aspetti? «Mi ritengo fortunata perché ho un compagno che comprende perfettamente quello che faccio e riusciamo a gestire insieme le esigenze lavorative e personali», chiarisce Giulia. «Solo così è possibile portare avanti l’attività professionale e trascorrere senza rimorsi le serate a lavorare». In Italia, come d’altra parte nei Paesi mediterranei le posizioni di rilievo non sono certo occupate da donne, e questo vale per tutti i settori purtroppo. In Italia poi il ruolo del ricercatore non viene riconosciuto come un lavoro. Giulia, per 15 anni ha potuto portare avanti le sue ricerche grazie alle borse di studio. Cosa che non succede all’estero. «Ho scelto di rimanere nel nostro Paese perché i laboratori qui da noi non hanno nulla di meno rispetto a quelli nel resto del mondo», racconta Giulia ,«Ho voluto investire qui in Italia, anche se con molti rammarichi. Un esempio, i ricercatori con esperienze all’estero vengono anche premiati con più punti nei bandi di concorso». Giulia fa parte del comitato di equality gender che si occupa di livellare le differenze di genere e quelle interculturali. E nella sua carriera, ci tiene a sottolineare, non ha mai assistito a episodi di razzismo. Ma spesso ha assistito a situazioni dove la donna veniva trattata diversamente. Difficoltà, queste, che non le hanno fatto venire meno il desiderio di fare ricerca. «A una giovane che intende intraprendere questa strada, consiglierei di sicuro di fare le sue debite valutazioni, è una carriera che richiede sacrificio e la capacità di gestire bene la pressione. In più, il lavoro scientifico non è solo stress, ma anche frustrazione perché non sempre i risultati che noi otteniamo corrispondono a ciò che ci aspettiamo. Nella mia carriera, mi è capitato di lavorare quattro anni a una ricerca senza poi in conclusione firmare il lavoro scientifico. Ma c’è anche un lato positivo, che è quello di buttarsi in un lavoro che dà sempre qualcosa. Per svolgerlo però richiede tanta curiosità, solo così non si rimarrà mai deluse». Quanto è bello un lavoro scientifico col proprio nome in prima fila? «E’ come ricevere il pagamento del lavoro svolto, la possibilità di condividere il risultato di anni di fatica e di sacrifici, il risultato più grande per un ricercatore. Anzi, per una ricercatrice».
Monica Niger ha 34 anni e svolge due attività: ricercatrice e dirigente medico, presso l’oncologia medica 1 dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, diretta dal prof. De Braud. Per dirla in parole semplici, è alla costante ricerca di nuove strategie, ma ha anche la possibilità di capire “sul campo” come orientarsi, perché i pazienti li segue dal punto di vista medico. «L’ Istituto è da diversi anni la mia seconda casa, qui ho fatto anche il mio percorso di scuola di specialità», racconta. «Ora sono oncologo medico nell’unità che si occupa dei tumori gastrointestinali e mi occupo di tumori del pancreas e delle vie biliari, sia da un punto di vista clinico, sia per quanto riguarda la ricerca. L’ultimo anno di specialità l’ho trascorso all’università di Yale nel Connecticut, negli Stati Uniti dove ho lavorato sia in clinica, sia in laboratorio. È stata un’esperienza molto importante per me, per cui il prof de Braud e l’istituto mi hanno supportata». Quando ha deciso di dedicarsi alla ricerca, oltre che alla clinica? «La mia decisione è nata durante la specialità, ho visto che non ero interessata solo ai nuovi sviluppi, ma a prenderne parte e a cercare sempre quel qualcosa in più. Per ogni paziente che si visita in ambulatorio, si pensa, “come si può migliorarne la situazione?”. è così che aumenta la voglia di andare avanti, sotto la spinta di un fuoco capace di autoalimentarsi e crescere nel tempo. Così è stato per me e spero continui ad esserlo.» Un anno negli Stati Uniti e poi è rientrata in Italia. Se pensa al suo futuro, dove se lo immagina? «La decisione di rientrare in Italia non è stata facile, perché le opportunità che mi si erano state offerte negli Stati Uniti erano molto interessanti. Alla fine, sono tornata perché credo nella ricerca in Italia. Le difficoltà non mancano e sono ben note e non ci sono sempre le risorse economiche disponibili, ma c’è sempre tanta voglia di fare. Ho visto colleghi e mentori, come la dott.ssa Di Bartolomeo ed il dott. Pietrantonio, con cui lavoro da anni, sviluppare progetti di altissimo rilievo con pochi mezzi. Penso che questo sia qualcosa che possiamo fare in particolare noi italiani, grazie alla capacità di inventiva e di risposta alle difficoltà.» Quanto riesce a gestire una vita professionale impegnativa e la sfera privata? «Sono conscia che come donna ci possano essere delle difficoltà pratiche, di equilibrio tra vita personale e lavorativa, però per ora la voglia di fare prevale su tutto. Ho un compagno eccezionale che fa fronte alla situazione. Non è facile vivermi accanto, con tutti i pensieri e problemi che comportano il lavoro di ricerca e la clinica. Per questo mi ritengo fortunata, lui e la mia famiglia sono molto di supporto. Certo, ho perso qualche amico, però ne ho altri che anzi mi incoraggiano, anche tra i colleghi, perché si rendono conto che questo per me non è solo un lavoro, è parte di quello che sono, è il mio approccio alla vita.» Cosa consiglierebbe a una ragazza che in questo momento sta pensando di dedicarsi alla ricerca? «Deve capire cosa vuole, cosa la appassiona veramente, se è solo la clinica, cioè curare il malato, va benissimo perché è un lavoro bellissimo. Se invece è la ricerca, e se c’è la voglia di trovare nuove risposte, allora va bene “fare il salto”. Si conoscono tante persone, sia pazienti e associazioni che colleghi e gli stimoli sono sempre tanti.» Quanto è emozionante il proprio nome su uno studio clinico? «Molto, e questo sempre. Talvolta, è il frutto di un coinvolgimento breve, altre volte è l’attività intensa e protratta per mesi o addirittura anni, e in tal caso il proprio nome sul Paper può rappresentare la chiusura di un cerchio, ma spesso anche l’inizio di un nuovo progetto. È il bello della ricerca.»